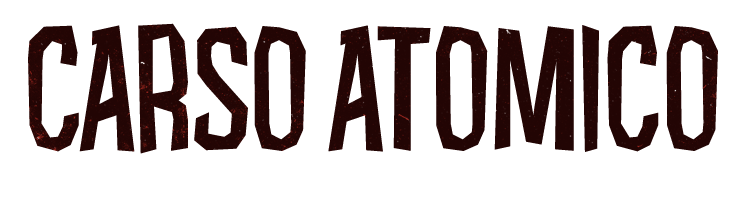Danjel «Skup» Skupek conficcò la pala nel terreno sperando in un bel proiettile da mortaio, una granata, una qualsiasi ferraglia delle due guerre mondiali progettata per esplodere.
La landa carsica congelata era dura come l’acciaio e scavare con la pala da giardinaggio era una faticata atroce. Gli toccava lavorare ingobbito, ma almeno poteva osservare la buca da vicino e assicurarsi che la vanga non urtasse qualche spoletta.
Contò le badilate cercando di tenere un ritmo decente mentre Tito lo guardava spaparanzato col muso sulle zampe.
Cinque… sei… sette…
A quota ventinove i muscoli delle braccia erano già in fiamme.
Si fermò a riprendere fiato mentre la luce grigiastra dell’alba iniziava a filtrare tra le nubi. Frugò nello zaino, trovò il cartone di rosso mezzo pieno e se lo scaricò in gola fino all’ultimo goccio.
Ruttò, attese che il sollievo si facesse largo nei muscoli e nel petto e si rimise al lavoro.
La brina scintillava sulla distesa d’erba selvatica cinta dalla boscaglia. In lontananza, una tozza torretta d’osservazione della guerra fredda spuntava dal terreno come un enorme fungo blindato. L’unico rumore era il raschiare della pala.
La montagnola di terra smossa gli era arrivata al polpaccio, ma nella buca non era affiorato niente a parte radici e sassi. La situazione lasciava poco spazio all’ottimismo.
Ricominciò a contare le badilate.
Interra… spala… interra… spala… interra…
Tito rivolse il muso verso la vegetazione e ringhiò.
Skup si bloccò e tese l’orecchio.
Rumore di fogliame e rametti che si spezzano.
Merda. Qualche rompipalle mattiniero in arrivo.
C’era abbastanza luce per notare un punkabbestia di mezza età che scavava in mezzo al Carso.
Puntò un cespuglio per nascondersi, ma si mosse troppo tardi.
Una tizia atletica in mountain bike schizzò fuori dalla macchia d’alberi pedalando a tutta birra. Il sentiero la condusse dritta di fronte a lui.
La donna incrociò il suo sguardo e cacciò un urlo. Ruotò a destra il manubrio e gli sfrecciò accanto. Perse il controllo della bici e strisciò contro un albero a lato del sentiero.
Finì col culo per terra e la gamba incastrata tra i tubi del telaio.
Tito la raggiunse abbaiando e rimase a scorrazzarle attorno.
Skup sbuffò e s’incamminò verso la tizia, augurandosi di limitare al minimo la rottura di palle. La gente pensa subito al peggio quando si trova a tu per tu con due metri per cento chili di pelle legnosa e barba color ratto avvolti in un impermeabile militare.
– Tutto ok?
– Non avvicinarti! – La donna mimò un alt con la mano che tremava, mentre con l’altra attaccò a digitare sul cellulare che teneva fissato al manubrio.
Skup si fermò e lasciò cadere la pala, che probabilmente stava lanciando il messaggio sbagliato.
La donna staccò il cellulare dal manubrio e lo mostrò a Skup.
– Sta’ lontano o chiamo i carabinieri! – Lo guardò con occhi sbarrati, manco fosse lì lì per farla a pezzi.
Bella rottura, per uno che voleva solo starsene per i cazzi suoi a bere.
Skup alzò le mani, indietreggiò di un passo e richiamò Tito con un fischio. Il cane smise di abbaiare e rimase a osservare la donna che cercava di liberarsi.
La tizia disincastrò la gamba dal telaio, incespicò e si appoggiò con la schiena all’albero. Tirò su la bici in fretta e furia, cacciò il cellulare nel marsupio e si rimise in sella. Pedalò via a rotta di collo.
Skup attese che il fruscio delle ruote sul sentiero sfumasse nel silenzio.
Cercò nello zaino un altro cartone di vino. Un gesto automatico: sapeva di aver finito le scorte.
Al diavolo. Riprese a spalare.
Contò altre trenta badilate e iniziò a dubitare del fiuto del cane.
Possibile che Tito si fosse sbagliato di nuovo? Magari il leggendario olfatto dei labrador calava con l’età. Era un pezzo che non trovava niente di decente.
BONG!
La pala da giardinaggio aveva toccato qualcosa di metallico.
– Bravo cane.
Prelevò una rotella di würstel dal sacchetto e gliela lanciò. Tito l’acchiappò al volo e la mandò giù.
S’infilò con gli scarponi nella buca e scavò con le mani più veloce che poteva. Lo stesso entusiasmo del primo ritrovamento: Carso sopra Aurisina, bomba aerea da cinquecento libbre. Aveva venduto l’esplosivo a un napoletano che si fabbricava i petardi per il capodanno.
Fantasticò su quel che avrebbe trovato ‘sta volta. Una granata tedesca col manico di legno? Un caricatore di mitragliatrice? Una lama da trincea della Grande Guerra? Pugnali e baionette avevano poco mercato tra i collezionisti, ma visti i tempi di magra non avrebbe fatto lo schizzinoso.
Un tombino arrugginito.
Forma circolare, superficie bombata e liscia. Largo un metro. Massiccio, niente maniglie o passanti.
– Merda, ma è l’oleodotto. Ridammi quel würstel!
Tito non sembrava esattamente in preda al senso di colpa, né intenzionato a restituire il suo spuntino.
Un’altra spedizione a vuoto. Cos’è, la decima in un mese?
Tirò fuori la vecchia cartina Tabacco su cui segnava tutti i ritrovamenti. Era tappezzata di appunti e segnaposti che andavano da San Martino del Carso alla Val Rosandra. Ci aveva messo un anno a raccoglierli, scarpinando sui terreni più bastardi che il Carso potesse mettergli sotto i piedi.
Stando alla mappa, la località si chiamava Gmajna: una radura isolata vicino a Doberdò del Lago, a un tiro di schioppo dalla Slovenia. L’oleodotto della Q8 correva a un paio di chilometri da lì.
Ok, non è l’oleodotto. Allora che diavolo è?
Si chinò, picchiò le nocche sul boccaporto e produsse un toc-toc sordo.
Accanto al tombino, la terra sprofondava in una piccola fenditura squadrata.
Imbracciò la pala e scavò tutt’attorno. Grattò contro un altro ostacolo duro.
Smosse la terra con le mani fino a svelare il lastrone di calcestruzzo che circondava il tombino. A venti centimetri dal boccaporto c’era un’intercapedine grande quanto un pacchetto di sigarette. All’interno era incastonato un tastierino numerico ossidato, simile a quello dei bancomat.
Ma che cazz…?
Si grattò la cute tra i dreadlock. Una botola sepolta da chissà quanto tempo sotto un metro cubo di terra e roccia. Hmmm…
Pescò dallo zaino il plico giallo con i documenti di lavoro.
Scartabellò il grosso fascio di fotocopie stropicciate fatte in biblioteca. Stralci di libri di storia locale, Grande Guerra, seconda guerra mondiale, articoli sulle armi d’epoca, pagine di giornali.
Era un habitué delle biblioteche della zona, specie d’inverno: ci si rintanava a leggere fino all’ora di chiusura, o fino a quando qualcuno non si lamentava della puzza. Col tempo aveva persino imparato a usare quel cazzo di internet e a stamparsi la roba che gli interessava.
Trovò ciò che cercava: un articolo del Piccolo del 2010. Titolo: «Doberdò, il mistero delle gallerie dimenticate».
Diede una scorsa al pezzo per rinfrescare la memoria. Adocchiò la botola e la torretta d’osservazione in fondo alla radura.
La zona brulicava di bunker e installazioni militari dei tempi della guerra fredda. Le torrette erano la punta dell’iceberg di un’enorme rete di gallerie sotterranee abbandonate.
E lui aveva appena trovato un modo per entrarci.
Magari là sotto è rimasto qualcosa da prendere.
Sorrise e con la matita disegnò un punto di domanda sulla cartina in corrispondenza della botola.
Digitò una cifra a caso sul tastierino.
Aveva l’aria di non funzionare da un pezzo, e infatti non successe niente: nessun rumore o movimento a indicare che quel coso potesse aprire il portello.
Al diavolo.
Piazzò la pala tra il calcestruzzo e il tombino e fece forza col piede.
Era come cercare di aprire una cassaforte con uno stuzzicadenti. Si appoggiò di peso sulla pala ma il boccaporto restò fisso. Serviva una cazzo di lancia termica per apr—
Bi-ri-bip!
Il radioscanner attaccato al cinturone aveva preso vita. Alzò il volume.
Interferenze. Un bip. Silenzio. Altre interferenze sovrapposte a una voce dall’accento meridionale.
Non aveva ancora imparato a decifrare il gergo sbirresco e distinse solo parole sparse.
«Volante dodici… Doberdò… sospetto… Carso… scavando…»
– Porco zio.
Quella cretina in mountain bike li aveva chiamati davvero i caramba.
Attaccò a seppellire la botola in fretta e furia.
Contò cinque badilate in dieci secondi.
Accelerò, ma gli parve di metterci più tempo a ricoprire la buca che a scavarla.
Una coppia di fari si fece strada tra gli alberi.
Merda.
Se erano i carabinieri, e Skup era troppo pessimista per ipotizzare scenari migliori, sarebbero avanzati a piedi per controllare e lo avrebbero raggiunto in pochi minuti. La strada provinciale per Doberdò si stendeva a meno di mezzo chilometro al di là della vegetazione.
Aumentò il ritmo e prese a pedate i mucchi di terra.
La buca era piena a metà. Cazzo.
Avvertì un conato acido in gola e si diede una mossa. Coi suoi precedenti, una tappa in caserma era cosa certa.
Finì di ricoprire la buca, appiattì la terra alla bell’e meglio e ci appoggiò sopra un grosso masso.
Infilò la pala da giardino nello zaino, se lo mise in spalla e si dileguò a passo svelto in direzione Trieste assieme a Tito.
Aveva davanti quattro ore abbondanti di scarpinata fino alla baracca sul monte Coste.
Abbastanza per pensare a un modo per aprire la botola.